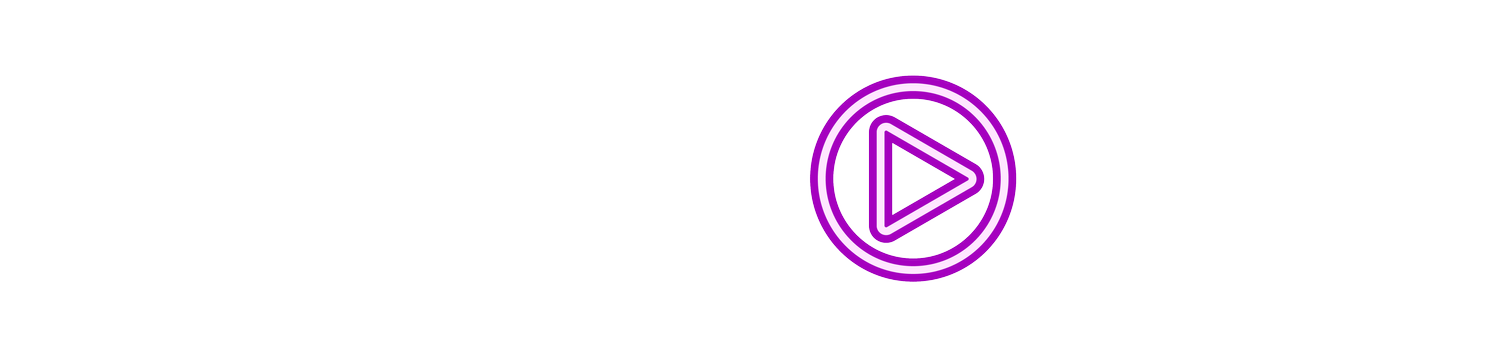Le belle estati, leggere Pavese nel XXI secolo
Tra gli autori più amati e celebrati del secondo Novecento italiano, Cesare Pavese rappresenta una figura di riferimento ancora oggi nella vita di molte persone, attraverso una scrittura in grado di lavorare nella brevitas in maniera profondamente introspettiva. Proprio su questa introspezione e sensibilità si basa Le Belle Estati, opera del 2023 di Mauro Sontini, disponibile su RaiPlay dopo il suo passaggio nello storico contenitore di cinema d’autore Fuori Orario.
Realizzato con la partecipazione del Liceo artistico Mengaroni di Pescara, il film si presenta come un’opera sperimentale, libera, girata senza copione e con mezzi di fortuna. Alla base de Le Belle Estati vi sono gli studenti del sopracitato liceo – impegnati nella produzione anche in ruoli più tecnici, come direttori della fotografia, operatori del suono, et similia – impegnati nella lettura di due dei testi di Pavese più celebrati: La Bella Estate e Il diavolo delle Colline, rispettivamente del 1940 e del 1948. Entrambi i romanzi sono incentrati sulle vite di giovani uomini e donne che vivono la loro vita nella città di Torino immersi nell’incoscienza e nell’esperienza della gioventù.
Il voler affidare la lettura di tali romanzi ai ragazzi e alle ragazze di oggi innesca un potente cortocircuito su cui verte l’intera pellicola. La giovinezza raccontata da Pavese e quella vissuta dai ragazzi si mescolano e si combinano in uno scambio continuo e simbiotico. Tale incontro, base fondante dell’intera operazione, tuttavia, più che “aggiornare” il modello pavesiano e focalizzarsi sui giovani protagonisti, rimarca l’universalità del testo di partenza, vero e proprio imprinting e modello attraverso cui Sontini legge le nuove generazioni e la contemporaneità, costrette nel modello scritto da Pavese circa ottant’anni fa. Un modello, quello di Pavese, sicuramente universale e che riesce a parlare a tutti, ma che non riesce a tenere traccia di come le cose son cambiate nel corso degli anni: tale giustapposizione, dunque, non sembra beneficiare entrambe le parti, ma solo quella già più affermata.
Oltre a quella della giovinezza, Le Belle Estati è ricco di cortocircuiti interessanti, non ultimo quello tra la creatività di Pavese giustapposta a quella degli studenti del liceo artistico, sia nelle loro lezioni curricolari, sia in quella messa in gioco dagli stessi nella produzione del film. Tale discorso artistico viene sottolineato a più riprese dalla rottura continua della quarta parete, attuata con diversi escamotage – dalla moltiplicazione degli attori per un singolo ruolo, utile a sottolineare anche la facilità di immedesimazione nei personaggi dell’autore torinese, fino alla continua esibizione dei mezzi utili alla produzione stessa del film.
Questi cortocircuiti, questi elementi idiosincratici che compongono il film lo rendono completamente libero da quelle che sono le logiche produttive tradizionali, allineandolo dunque alla poetica del suo regista nel tentativo di creare un “nuovo cinema contemporaneo”. In questo senso, Le Belle Estati rappresenta un tentativo interessante di costruire forme di cinematografia nuove, inesplorate. Non sempre, almeno per chi scrive, questa forma di cinema proposta da Sontini funziona (soprattutto nel modo in cui tratta e approccia le nuove generazioni), ma è quantomeno ammirevole il tentativo e lo sforzo di rinnovamento.