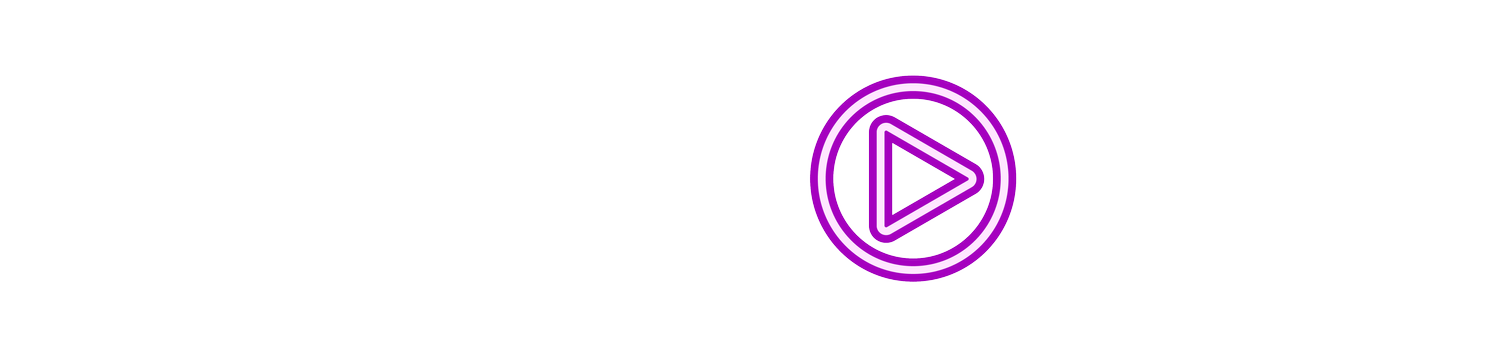X-MEN ‘97: un prodotto tanto riuscito quanto “inutile”
Che la Marvel sia in uno stato piuttosto confusionale, è ormai pressoché appurato. Così come è oggettivo che, esattamente come dicevamo ai tempi della seconda stagione di Loki, è proprio quando la Casa delle Idee lavora sul passato che prendono piede i lavori più convincenti. X-Men ’97 è l’ennesima conferma di questa tendenza. Il gusto retrò, va da sé, si concretizza a cominciare dal titolo dello show: una serie animata che riporta indietro le lancette e torna a narrare le storie del più celebre gruppo di mutanti del mondo a fumetti esattamente da dove le precedenti cinque stagioni degli Insuperabili X-Men si erano concluse (proprio nel 1997, ca va sans dire). L’occasione diventa quindi più che golosa per due aspetti intrecciati e connessi vicendevolmente: da una parte sfruttare la carta della nostalgia, tanto cara al marketing e alla narrazione contemporanei; dall’altra dare vita a una vera e propria caccia al tesoro, uno show seriale che può trasformarsi ben presto in un quizzone televisivo in cui dare prova del proprio grado di nerdismo grazie a easter eggs, riferimenti, rime interne e chi più ne ha più metta.
Lungi da noi soffermarci su questo aspetto, così come sul travaglio produttivo che non sembra dare pace ai progetti audiovisivi marcati Marvel dedicati al professor Xavier e i suoi dotati alunni, quello che davvero risulta interessante in X-Men ’97 è notare quanto si tratti di un prodotto tanto riuscito quanto “inutile”. Senza troppi giri di parole, la componente grafica, estetica e narrativa della serie funziona a pieni voti. Nel giro di pochi istanti, il pubblico viene catapultato in un’altra epoca, in un passato decisamente prossimo ma che, per via delle avanguardie tecnologiche che hanno coinvolto il mercato animato nelle ultime decadi, risulta non solo remoto, ma praticamente sepolto. Eppure, per chi è cresciuto con la televisione di quegli anni, sarà impossibile non godere di un simile ritorno (al futuro). Dal montaggio al sound design, dalla grafica bidimensionale e monocromatica allo script di ogni puntata: tutto è orchestrato a meraviglia per ricalcare in stile carta carbone una narrativa e una creatività ormai superate.
Resta però da chiedersi, al di là dell’omaggio genuino e sincero, cosa rimanga a conti fatti di tutto questo. Anche perché, a fronte di un episodio oggettivamente importante e corposo (il quinto, non a caso posizionato al centro dello show, nel cuore pulsante del progetto), tutto il resto risulta ampiamente godibile ma allo stesso tempo innocuo e dimenticabile. Vero che l’intrattenimento contemporaneo si sta muovendo proprio su simili binari, insistendo su una superficie sempre più evanescente, luccicante e poco segnante, preferendo lasciar risplendere i riflettori invece che sposare una ricerca più profonda e, per questo motivo, indelebile. Tuttavia è anche vero che a lungo andare Marvel dovrà necessariamente tornare a costruire un immaginario, un pubblico, un’emozione aggregativa invece di provare incessantemente a scomodare l’usato sicuro, di sfornare minestre riscaldate e far leva sulle greatest hits sempreverdi per risollevare le sorti di un brand che ha smesso da tempo ormai di ispirare i nuovi orizzonti dell’intrattenimento popolare.